Storia medievale di un ladro acrobata
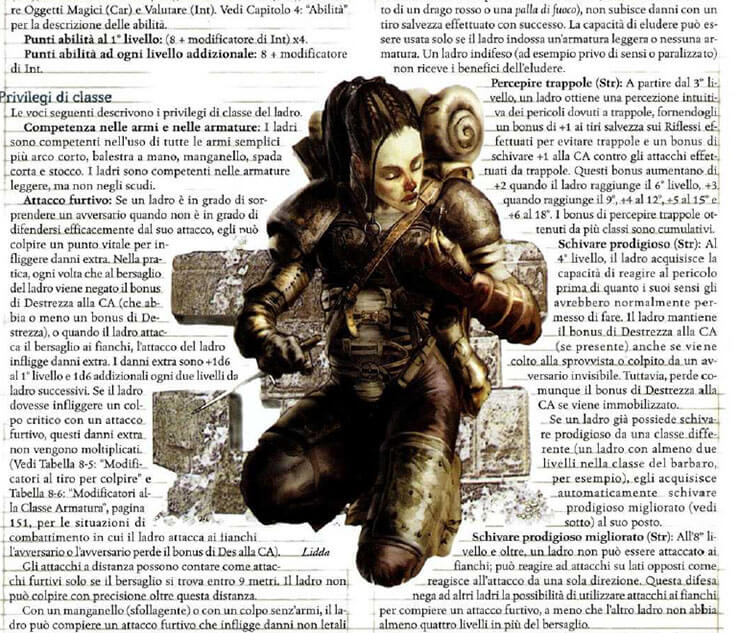
La figura del ladro acrobata nelle antiche cronache medievali: dalla realtà storica di Giovanni Villani al fantasy di Dungeons and Dragons
Una tipologia di personaggio che ricorre spesso nella narrativa fantastica contemporanea è quella del ladro acrobata. Una figura che compare non solo in thriller e opere avventurose, ma anche nelle ambientazioni fantasy di stampo medievale, come lo sono le infinite eredità lasciateci da “Il signore degli anelli”. Fra i membri di una compagnia di personaggi che presentano ciascuno determinate abilità e poteri troviamo sempre quello furtivo, agilissimo, (e al tempo stesso truffaldino), tutti elementi già presenti nei resoconti storici medievali, a partire dalla variante più letale, e celebre, di questo personaggio: ovvero l’assassino.
Il mito dell’assassino comincia a diffondersi in Occidente dal XII secolo per indicare alcuni “saraceni che, nel loro dialetto, si chiamano Heyssessini“1 Quel che sappiamo sul loro conto non è molto, ed è inquinato da antiche leggende arabe a loro volta reinterpretate dai cristiani, come avviene nel “Milione” di Marco Polo2, dove si narra di Alamut, Nido dell’aquila, la leggendaria fortezza dell’Ordine degli Assassini situata a quasi duemila metri d’altezza. Fra le antiche mura di pietra il Veglio della Montagna praticava la sua dottrina, istruiva i seguaci e conferiva loro incarichi pericolosi: l’assassinio dei più eminenti membri della società dell’epoca per scopi politici e militari. Tali incarichi venivano svolti tramite l’utilizzo di travestimenti e stratagemmi, proprio come ci si aspetterebbe in un film o in un videogioco della serie Assassin’s Creed: una storia, quella dell’Ordine degli Assassini, che approfondisco in un episodio di Leggende Affilate dedicato, che consiglio assolutamente di recuperare.
Oggi invece voglio concentrarmi sulla nostra storia. Perché di ladri acrobati si fa menzione anche nelle cronache italiane a cominciare dalla Nuova Cronica di Giovanni Villani, di metà Trecento. La cronaca che ci ha regalato la storia di un eccellentissimo ladro, italiano e più precisamente toscano, di nome Arrighetto di san Polo: abile e letale. Ma facciamo un passo indietro.
Piero, detto Saccone per la sua stazza “massiccia e poco aggraziata“3, fu il signore della casata dei Tarlati, proprietari di vari castelli sparsi per il centro Italia. Era stato nominato cavaliere dall’imperatore stesso, quindi di parte ghibellina, e aveva mire espansionistiche verso alcune località che rivendicava come proprie secondo vecchi privilegi. Ed è per questo che con l’aiuto dei suoi conti e degli alleati mise in piedi un’armata composta da “quattrocento cavalieri dell’arcivescovo di Milano e cento di suo sforzo”4 per cominciare la sua campagna militare. Direzione: Borgo San Sepolcro (oggi chiamata semplicemente San Sepolcro, nella provincia di Arezzo, in Toscana).
“Il borgo a san Sepolcro, terra forte e piena di popolo e di ricchi cittadini, e fornita copiosamente d’ogni bene da vivere, era nella guardia de’ Perugini con due casseri forniti alla guardia dei castellati perugini e di gente d’arme.”
L’obbiettivo del Saccone era una città fortificata come lo erano in prevalenza molte realtà urbane dell’Italia centro-settentrionale: “terra forte e piena di popolo e di ricchi cittadini“, condizione che giustifica la presenza di così tanti mercenari stranieri giunti nel Bel Paese per arraffare una fetta di ricchezze nostrane. Il borgo era presidiato da una guardia di Perugini che esercitavano una sorta di protettorato sulla città, forti di molte genti d’arme e di due “casseri” termine con cui si indicavano le fortificazioni principali e più massicce del sistema difensivo. Insomma, la presa del borgo non poteva essere definita come una passeggiata.
Il Saccone, inoltre, non aveva intenzione di svernare fuori dalle mura in un lungo e logorante assedio. Volle trovare un modo di risolvere la faccenda alla svelta e conosceva la persona giusta per farlo: tale Arrighetto di san Polo, meraviglioso ladro acrobata.
“Messer Piero aveva con sé uno suo fedele che aveva nome Arrighetto di san Polo, questi era grande e maraviglioso ladro, e facea grandi e belli furti di bestiame, traendo i buoi delle tenute murate e guardate, e rompeva tanto chetamente le mura, che niuno il sentiva, e di quelle pietre rimurava le porti a’villani di fuori sì contamente, che prima veva dilungate le turme de’buoi, e tratte per lo rotto del muro due o tre miglia che i villani trovandosi murate le porti, e, impacciati dalle tenebre della notte e dalla novità del fatto, le potessono soccorrere.”
Arrighetto era conosciuto soprattutto per i suoi “grandi e belli furti di bestiame”, svolti in maniera così furtiva che nessuno si accorgeva mai della ruberia, se non a cose fatte. Arrighetto rompeva le barriere che tenevano rinchiusi i capi di bestiame, faceva uscire “le turme de’buoi“, poi con le pietre rimosse dalla barriera murava le porte dei villani, i proprietari, chiudendoli nelle loro case. Prima che i villani riuscissero a venir fuori dall’uscio sbarrato, Arrighetto se l’era già svignata, allontanandosi di “due o tre miglia“.
Ma non era solo un ladro di vacche. Come ci racconta il Villani nella sua cronaca, si trattava di un meraviglioso ladro acrobata, “che saliva su per li canti delle mura e delle torri co’ suoi lievi argomenti incredibilmente, e quanto che fossono alte non se ne curava, ed era dell’altezza maraviglioso avvisatore.“
“(Piero) s’intese con uno de’ Boccognani del borgo e grande ghibellino il quale odiava la signoria de’ Perugini e da lui ebbe che se la porta e la torre fosse presa, e di fuori fosse forza di gente a cavallo e a piè grande, ch’egli con gli altri ghibellini d’entro verrebbono in loro aiuto a metterli dentro. E dato l’ordine tra loro, messer Piero con cinquecento cavalieri e duemila pedoni un sabato notte, a dì venti del mese di novembre del detto anno, improvviso a’Borghigiani, innanzi il dì fu presso al borgo.”
Un sabato notte, Saccone chiese al ladro acrobata di scalare una torre della città assediata, una di quelle torri che proteggevano i vari ingressi di borgo san Sepolcro. Una volta in cima, Arrighetto avrebbe dovuto aprire le porte, di sotto, per far passare gli attaccanti, mentre i ribelli ghibellini nascosti in città si tenevano pronti alla rivolta, pronti a uscire in strada a dar man forte.
“Mandato Arrighetto con certi masnadieri eletti in sua compagnia a prendere la torre e la porta, il detto Arrighetto con suoi incredibili argomenti in quello servizio, cintosi corde, e aiutato di non essere sentito per uno grande vento che allora soffiava, e avea ristrette le guardie sotto il coperto, montò in su la torre della porta, ed essendovi due sole guardie, si recò il coltello ignudo in mano, e mostrò d’avere compagnia, minacciandoli d’uccidere. Eglino storditi per la novità, non sapendo che si fare, stettono cheti per paura, e Arrighetto data la corda a’masnadieri ch’erano a piè del muro, con una scala leggieri di funi tirò su l’uno dei capi e accomandollo a uno de’merli, e incontamente montati suso per quella l’uno appresso l’altro dodici masnadieri.”
Arrighetto, che non aveva cognome poiché uomo semplice, proveniente da san Polo, accettò la missione: si avvicinò alle mura della città e s’arrampicò su per la più alta torre, al di sopra della porta d’ingresso, portando con sé una lunga corda. Una volta giunto in cima senza esser visto, grazie all’oscurità e al vento forte che copriva i rumori, piombò addosso alle due guardie che si trovavano lassù, e le minacciò con un coltello. Le guardie perugine, completamente colte alla sprovvista, si arresero senza neppure combattere.
Arrighetto legò un capo della lunga corda attorno a un merlo della torre, la srotolò di sotto, e fece salire dodici masnadieri del Saccone, che avevano atteso ai piedi delle mura, nell’ombra.
“E quando si vidono signori della porta, feciono a quelli traditori d’entro certo segno ordinato. Quello de’Boccognani veduto il segno come la porta era presa, fece sonare a stormo una campana d’una chiesa, al cui suono, come ordinato avea, tutti i ghibellini del borgo furono all’arme e traevano verso la porta. I guelfi che non sapeano il tradimento traevano storditi alla piazza senza niuno capo; e schiarito il dì, vedendo aperta e presa la porta per i ghibellini, e sentendo come messer Piero era di fuori con molta gente, non vedevano da potere riparare; ma i ghibellini non volendo guastare la terra assicurarono i guelfi che ruberia non vi si farebbe, e senza contrasto vi lasciarono entrare messer Piero con tutta la sua gente e del conte Pallavicino, e non vi si diè colpo e non vi si fece alcuna ruberia: e così messer Piero ne fu signore.”
A quel punto, dopo che la torre era stata conquistata, Arrighetto lanciò un segnale che non ci viene descritto, per avvertire un campanaro ghibellino di suonare all’impazzata. La campana di una chiesa di san Sepolcro cominciò quindi a rintoccare nella notte: avvertendo i ghibellini in attesa che era il momento d’entrare in azione. I rivoltosi in armi scesero in strada e si diressero alla torre conquistata dal ladro acrobata, aprendo le porte e facendo entrare il Saccone con tutto l’esercito.
Il Saccone coi suoi cavalieri giunse in città senza colpo ferire, né ruberia alcuna. Poiché il signore dei Tarlati non voleva “guastare la terra” di coloro che lo avevano aiutato.
“Ma le due rocche che erano forti e guardate per li Perugini si misono alla difesa per attendere il soccorso de’Perugini. Messer Piero e il conte senza prendere soggiorno con tutta la sua gente a cavallo e a piè uscirono del borgo, e accamparonsi di fuori dirimpetto alle rocche per la via a’Perugini, e fecionsi innanzi al loro campo fare un fosso di subito e uno steccato, e mandarono a tutte le terre dov’avea gente d’arme del signore di Milano che mandassero loro aiuto, e in pochi dì vi si trovarono con ottocento cavalieri e popolo assai.“
I soldati perugini si asserragliarono nelle due rocche fortificate (i casseri) per tentare una difesa a oltranza, ma dopo le azioni rocambolesche del ladro acrobata e la pressione armata del Saccone, i difensori infine crollarono. L’intero borgo capitolò con le sue due rocche, e pure nelle città vicine si sparse la voce della viltà di “coloro che gli aveano in guardia“.
Dopo la conquista del borgo di san Sepolcro, di Arrighetto di San Polo, il ladro acrobata medievale, non ne se ne seppe più niente. Chissà che non sia tornato a fare “grandi e belli furti” per tutta Italia, oppure che si sia messo a compiere pericolose missioni al soldo di qualche signore. Di lui resta solo questa minuta ma affascinante traccia nelle cronache.
Se questa storia ti ha appassionato, seguimi. Perché di Leggende Affilate è piena la storia. Alla prossima.
Segue la cronaca del capitolo XLIII “Come i perugini arsono intorno al borgo e sconfissero de’nemici”:
“I Perugini turbati di questa perdita procacciarono da ogni parte aiuto per racquistare la terra, tenendosi i casseri, e di presente ebbono cinquecento cavalieri dai Fiorentini: e con millequattrocento cavalieri e con grande popolo se nè vennono alla città di Castello e acconciatosi per soccorrere quei de’casseri.”
“Tanta viltà fu in coloro che gli aveano in guardia, che senza attendere il soccorso così vicino s’arrenderono a messe Piero; e incontamente quelli del castello d’Anghiari cacciarono la guardia che v’era de’Perugini, e dieronsi al vicario dell’arcivescovo, ed egli lo rendé a messer Maso de’Tarlati. In que’ di il castello della Pieve a santo Stefano e i castello perugino, tenendosi mal contenti de’Perugini, anche si rubellarono da loro.“
“I Perugini avendo perduta la speranza di soccorrere le rocche, cavalcarono al borgo, e arsonlo intorno guastando tutte le possessioni, e già messer Piero e’l conte Pallavicino non ebbono ardire d’uscire della terra contro a loro: e fu fatto il guasto, si tornarono alla città di Castello. Messer Piero preso suo tempo con tutta la cavalleria ch’avea nel borgo cavalcò fino alle porti della città di Castello: i cavalieri che v’erano dentro de’Perugini, e singolarmente quelli de’Fiorentini, ch’erano buona gente d’arme e bene montati, uscirono fuori perché i nemici aveano a fare lunga ritratta, e seguitando i nemici quasi a mezzo il cammino, s’abbatterono in un grosso agguato: e ivi cominciò l’assalto aspro e forte, ove s’accolse la maggiore parte della gente di catuna parte senza fanti a piede; e ivi dando e ricevendo si fece aspra battaglia, e durò lungamente, perrocché catuno voleva mantenere l’onore del campo; e non avendo pedoni che l’impedissono, feciono i buoni cavalieri grande punga, e in fine per virtù di certi conestabili della masnada de’Fiorentini, ristringendosi insieme, con impetuoso assalto ruppono la cavalleria di messer Piero, e a forza in sconfitta gli cacciarono del campo, e rimasono morti sessanta de’loro cavalieri in sul campo e più cavalli, e presi sei de’loro conestabili da’ cavalieri de’Fiorentini, e messer Manfredi de’Pazzi di Valdarno, e più altri cavalieri tedeschi e borgognoni, a’quali tolsono l’arme e’cavalli secondo l’usanza e lasciaronli alla fede: e questo fu del mese di dicembre del detto anno.“
- John Rackam Alias Calico Jack - 7 Luglio 2024
- Mary Read: una piratessa dei Caraibi - 30 Giugno 2024
- Anne Bonny: una vera donna pirata - 23 Giugno 2024


